I possibili scenari di politica estera nell’America di Trump o Harris
Sembra probabile che dopo il 5 novembre la rotta degli Stati Uniti sulla scena internazionale possa essere destinata a cambiare. Le differenze di prospettive tra Harris e Trump nel punto di Stefano Marroni
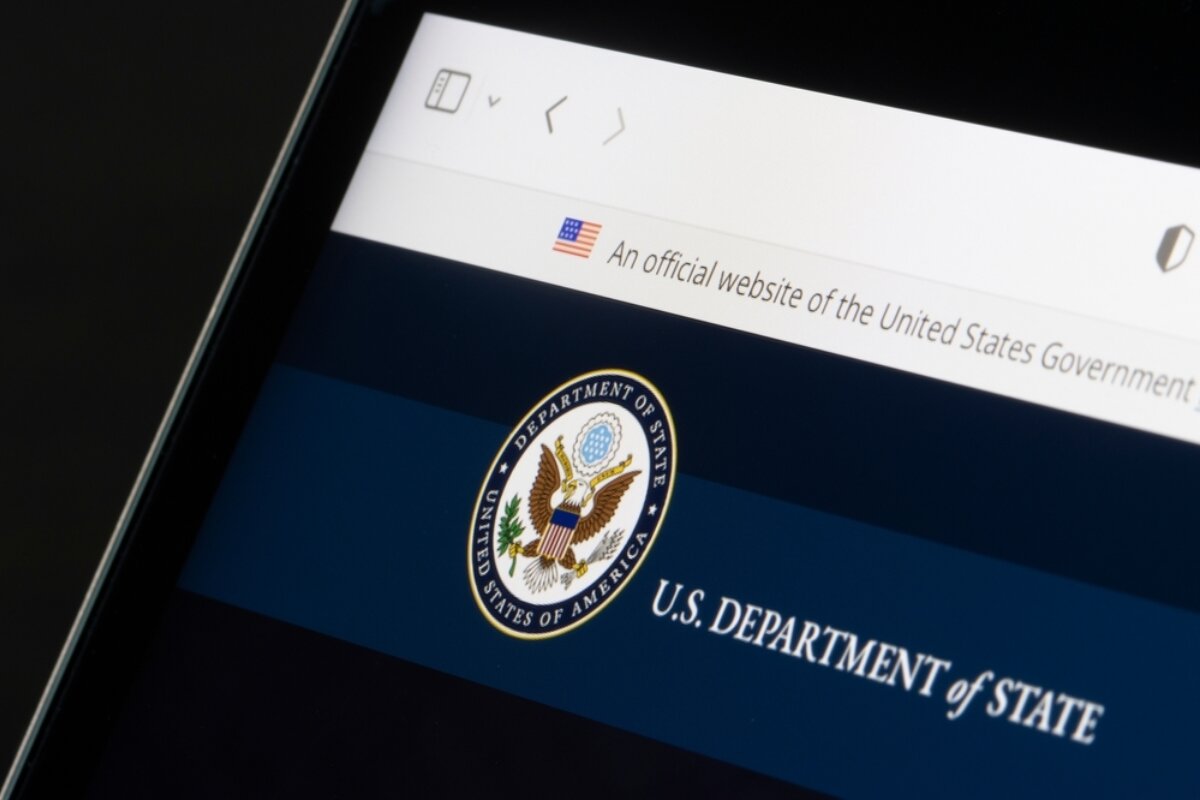
Non è stato mai il cuore della campagna, della sfida furibonda da cui tra pochi giorni emergerà il nome del nuovo inquilino della Casa Bianca. Mai forse come questa volta – da una parte per gli americani furiosi per il boom dell’immigrazione clandestina e i morsi dell’inflazione sui loro redditi, dall’altra per quelli indignati per l’attacco all’aborto e impauriti dal ritorno di Donald Trump a quattro anni dal 6 di gennaio - la politica estera non ha costituito un elemento centrale di attenzione durante la volata che ha visto Kamala Harris prendere in corsa il posto di Joe Biden. Un paradosso – con due guerre in corso, e il proliferare di crisi in ogni angolo del mondo – reso ancora più stridente dalla consapevolezza diffusa degli osservatori e delle cancellerie che in ogni caso, dopo il 5 novembre, la rotta degli Stati Uniti sulla scena internazionale è destinata a cambiare. Quale che sia il vincitore, e la squadra che definirà da Dipartimento di Stato, Pentagono e NSC le mosse dell’America.
Sullo sfondo, recitano tutti i report che in queste settimane sono apparsi sulla stampa internazionale, c’è l’evidenza di una perdita di trazione degli Usa come superpotenza in grado di influenzare in modo decisivo il corso degli eventi. Nell’arco di pochi anni, nell’area del Mediterraneo allargato, Washington si è vista presentare il conto degli errori di almeno un quarto di secolo: dalla catastrofe dell’Iraq allo scasso della Libia, dalla destabilizzazione della Siria allo strappo con l’Iran fino al disastro afgano, con tanto di bis a Kabul della indimenticata fuga da Saigon. Ma è in tutti gli scenari che Biden ha dato l’impressione di esser in balia degli eventi. L’Africa – il continente in cui si giocheranno partite cruciali nel prossimo futuro – è ormai quasi del tutto fuori dal controllo di Washington. In Europa, il sostegno finanziario e militare a Zelensky non ha convinto gli alleati – men che meno quelli del fianco Est e del Nord – che gli Usa abbiano giocato bene la lunga partita a scacchi che ha preceduto e seguito l’invasione dell’Ucraina.
Presa in contropiede dalla strage di Gaza mentre tesseva la tela di uno storico accordo tra i Israele e i sauditi, la Casa Bianca si è mossa freneticamente per una soluzione negoziata che non è riuscita a imporre a Netanyahu, pagando un prezzo alto con l’opinione pubblica internazionale e persino con settori dell’elettorato americano. E nello scenario più importante per gli americani – l’Indopacifico – la crescente pressione cinese su Taiwan e i segnali che fanno parlare di una nuova, possibile, guerra tra le Coree si intrecciano con un movimento politico che sembra allineare lungo l’asse Pechino-Mosca i giganti del Sud globale, a cominciare dall’India di Narendra Modi: “E’ chiaro che a uno scenario che cambia ci si deve adattare”, scrivono su Foreign Affairs Christopher Chivvis e Stephen Werthein. “Negli ultimi otto anni, Donald Trump e Joe Biden hanno tentato entrambi di far virare gli Stati Uniti in nuove direzioni e non ci sono riusciti, per fattori interni e internazionali. Ma le resistenze che hanno incontrato non sono una sorpresa. Fin dalla seconda guerra mondiale, molti leader ci hanno provato e ogni volta i loro sforzi sono andati a vuoto. L’inerzia è forza potente”.Inizio modulo
Stavolta, però, la portata delle difficoltà da gestire sembra dire che il nuovo Commander-in-Chief sarà obbligato a cambiare spartito. Per cogenti ragioni politiche e soprattutto di bilancio. E a questo scenario stanno sostanzialmente facendo la bocca sia i nemici dell’America - raccontano al Dipartimento di Stato – sia soprattutto gli alleati, che nei differenti teatri di tensione globale si accingono a misurare sia la differenza con il passato, sia lo scarto possibile nelle decisioni americane in caso di vittoria dell’uno o dell’altro candidato.
Su Foreign Policy, un commentatore di orientamento repubblicano come Matt Kronig scrive che se non vincerà Harris “le maggiori differenze le vedremo sul dossier Ucraina: Trump - spiega - è stato chiarissimo nel dire che il suo obiettivo è un negoziato che faccia finire la guerra in fretta, con un cessate il fuoco sulle attuali linee di demarcazione. Ha fatto capire che potrebbe tagliare il supporto militare se Zelensky non accettasse di negoziare ma anche che potrebbe dargli più di quel che ha mai avuto se fosse Putin a non voler trattare”. È l’idea di uno scambio tra pace e territori che non è fatto per far dormire sonni tranquilli ai vicini di Putin, così inquieti dalla prospettiva di una vittoria di “The Donald” da indurre Kamala Harris a puntare su questa paura anche nel rapporto con le comunità di origine est europea concentrate in stati decisivi come Michigan e Winsconsin, e con gli 800 mila americani di origine polacca che vivono in Pennsylvania. A maggior ragione dopo gli avvertimenti ruvidi del tycoon sulla necessità per gli alleati di affrettarsi a “pagare il conto” per contare ancora sull’ombrello americano.
Di certo pesa, sull’atteggiamento di Trump, un rapporto da subito molto difficile con Zelensky e la sua percezione di Vladimir Putin come di un partner affidabile, a cui “dire se serve le cose con durezza” ma da non provocare offrendo a Kyiv l’accesso alla Nato. Ma più in generale, chi ha lavorato con Trump sui dossier di politica internazionale liquida l’idea di un presunto appeasement con Mosca: “Dobbiamo convincere Putin che facciamo sul serio, dopo gli avanti e indietro di questi tre anni”, dice al New York Times Elbridge Colby, che con lui fu il numero due alla Difesa e stavolta è in corsa per il top job in caso di vittoria. “Per costringerlo a trattare, il peso della guerra deve diventare insostenibile: ma per farlo serve che soprattutto tedeschi e polacchi facciano di più. Perché c’è un problema generale: per la prima volta in più di un secolo, gli Usa non sono più chiaramente la più grande economia del pianeta, per non dire la più grande potenza industriale. Non potremo più essere il poliziotto del mondo. L’insieme dei nostri alleati è molto più ricco dei nostri nemici. Ma investe troppo poco in difesa e sicurezza. Tocca agli europei del Nord contenere Putin, e tocca a italiani, greci, francesi, spagnoli fare il lavoro che serve nel Mediterraneo allargato, come tocca a Taiwan e Giappone alzare l’asticella delle loro spese militari. Possiamo tenere ancora in Europa la metà dei cinquantamila uomini di stanza in Germania. Ma il resto delle truppe – conclude - va spostato al fronte: e il fronte è il Pacifico, da Guam alle Aleutine”.
Che sarà questo il leitmotiv delle politiche di difesa di un possibile Trump 2 lo sottolinea anche Robert O’Brien, che con “the Donald” fu dal 2017 al 2021 consigliere per la Sicurezza Nazionale, e che insieme a Mike Pompeo, Fred Fleitz, Matt Pottinger e Robert Lighthizer (l’uomo della guerra delle tariffe con Pechino e la Ue) molti a Washington indicano tra i probabili uomini del tycoon se il voto lo rimanderà alla Casa Bianca: “La minaccia esistenziale all’America, alla nostra esistenza, ai nostri figli e al loro modo di vivere vengono da una parte sola: che è il Pcc, Xi Jinping, le ambizioni di una Cina che va a tutto vapore per essere pronta a invadere Taiwan, e dunque alla guerra – come ha detto Xi - entro il 2027. Il resto viene obiettivamente dopo. Con un’eccezione: Israele. Sono i nostri più importanti alleati, e l’intero Occidente ha un debito di gratitudine con loro. Combattono con potenze molto più grandi di loro. Ma stanno vincendo, e dobbiamo aiutarli a vincere la lor guerra, invece di tentare di fermarli ad ogni passo. Lasciamogli fare quello che noi abbiamo fatto al Califfato, liberare gli ostaggi se si può ma poi distruggere Hamas, farla finita con Hezbollah. Se ci riusciranno - scommette O’Brien - il Medio Oriente sarà tutto un altro posto”.
E’ un capitolo, quello dei rapporti con Israele e il mondo arabo, su cui sull’altro fronte, nell’accampamento democratico, ci sono obiettivamente meno certezze di quel che riguardano da un lato l’approccio al dossier Ucraina e al ruolo della Nato (che si annuncia di continuità con Biden, al netto della pressione sugli alleati perché adeguino i loro budget alla necessità di fronteggiare la nuova minaccia russa) e dall’altro la sfida globale con la Cina di Xi, che ha visto Harris ventilare apertamente la possibilità di intervenire in difesa di Taiwan e sostanzialmente difendere la guerra di tariffe aperta con la PRC.
Non perché Kamala – che è oltretutto sposata con l’avvocato Doug Emhoff, cresciuto nella comunità ebraica di Brooklyn - si sia mai discostata in campagna elettorale dalla linea del “sostegno incrollabile” e del “rapporto blindato” che da decenni è il mantra di Joe Biden nei confronti di Israele: “Di tanto in tanto, però – ha notato su FP Steven Cook, un senior analist del Council on Foreign Relations – la vicepresidente si è smarcata, mostrando accenti più critici verso gli israeliani di quelli del presidente. E nelle sue dichiarazioni pubbliche non era difficile cogliere una maggiore enfasi - e anche una maggiore empatia – sulla drammaticità delle sofferenze dei palestinesi a Gaza”.
Su queste uscite hanno pesato probabilmente anche considerazioni tattiche sul rischio di perdere voti nell’elettorato giovane e tra i musulmani americani. Ma “senza dubbio gli orientamenti meglio definiti tra ciò che potrebbe cambiare con l’elezione di Harris – spiega l’ex ambasciatore alla Nato Ivo Daalder – riguardano soprattutto il Medio Oriente, perché nella squadra del vicepresidente c’è la consapevolezza piena che serve un nuovo approccio alla nostra politica nell’area, a cominciare dalle necessità di favorire davvero la nascita di uno Stato palestinese”.
Il riferimento alla squadra allude al ruolo centrale per la politica estera che in un’amministrazione Harris svolgeranno probabilmente il suo attuale consigliere per la Sicurezza nazionale Phil Gordon, un diplomatico di lungo corso che ha seguito e preso nota della lunga serie di fiaschi collezionati dagli Usa ripetendo il copione del regime change: un copione “in cui sistematicamente i politici sottovalutavano i rischi di rovesciare un regime – ha scritto - ne enfatizzavano la minaccia potenziale, facevano proprie le valutazioni ottimistiche di attori locali con poco potere e molti interessi, se ne dichiaravano prematuramente vincitori, per poi finire travolti dal caos e trovarsi alla fine a sopportarne i costi – in qualche caso più di un miliardo di miliardi di dollari e migliaia di morti americani – per molti anni e persino decenni”. È una linea, quella di Gordon, che intreccia la sua riflessione sui fallimenti del cosiddetto “eccezionalismo americano” a quelle di un’altra ascoltata consigliera di Kamala sulla necessità di “un approccio meno arrogante” alle cose del mondo. Se si esaurisce l’assetto unipolare – ha riassunto Rebecca Lissner – “occorre che si metta da parte anche qualsiasi illusione sull’abilità degli Stati Uniti di disegnare un ordine mondiale a loro misura”: in una visione che passi da “un’idea messianica” del ruolo dell’America alla presa d’atto che con la sua forza essa è il principale strumento per “preservare un sistema globale aperto”, in cui gli Stati Uniti “possano prosperare”.
È un percorso che riconosce gli eccessi passati e ridimensiona drasticamente, “da sinistra”, le ambizioni imperiali di un tempo: anche se “un’America forte rimane indispensabile al mondo”, dichiara Kamala, nel suo controcanto a Trump e alla sua scommessa di farla di nuovo grande, ma anche lui in realtà giocando su meno tavoli. Cosicché alla fine, su questa strada, inevitabilmente in politica estera le differenze tra l’America di Trump e quella di Harris potrebbero essere meno eclatanti di quanto ci siamo abituati a pensare. O al più – sostengono negli ambienti mainstream del Gop - legate più stile e alla cultura personale dei due leader che alla sostanza di scelte che – chiusa sperabilmente la guerra ucraina – sembrano comunque avere al centro la preoccupazione globale degli americani per il ruolo della Cina e la ricerca di un assetto nuovo per il Medio Oriente. Pochi giorni - sperando che il sipario cali senza strascichi sulla corsa affannosa di questi mesi - e il mondo saprà cosa l’aspetta.



