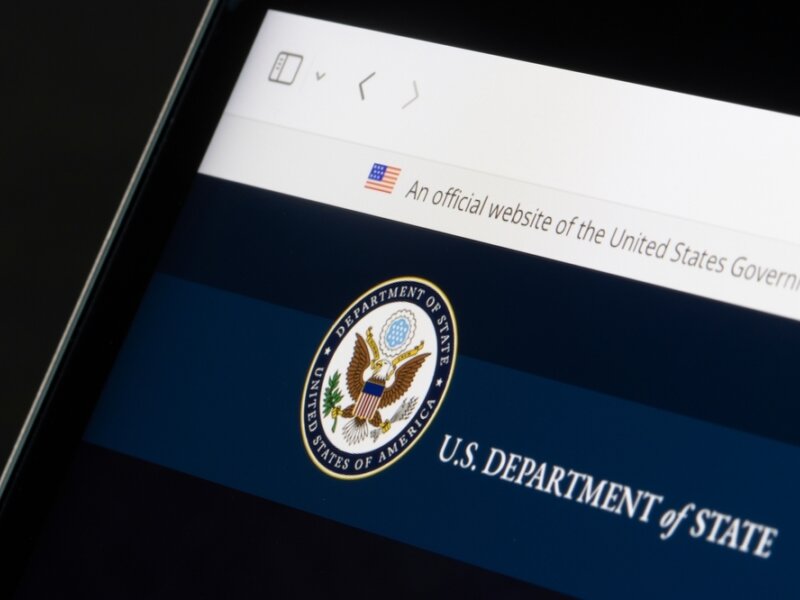Sudan, verso una transizione post-crisi
Con l’accordo tra militari e Primo Ministro, il Sudan riprende il processo di transizione. In questo quadro, è essenziale che Stati Uniti e Ue aumentino il proprio impegno. Il punto di vista di Daniele Ruvinetti

L'accordo raggiunto domenica 21 novembre in Sudan tra militari e Primo Ministro sembra reggere e aver riallineato il paese verso il processo di transizione interrotto quando i generali golpisti guidati da Abdel Fattah al Burhan avevano arrestato il premier Abdalla Hamdok, il 25 ottobre.
Al Burhan, presidente del Consiglio sovrano del Sudan, aveva sciolto il governo, dichiarato lo stato di emergenza, bloccato Internet e messo sotto controllo le infrastrutture centrali, intestandosi di fatto la guida del paese. Il Consiglio è l'organo istituzionale che affianca l'esecutivo nel processo di riconciliazione nazionale post-Bashir: sull'equilibrio delicato tra questi due poli di potere – oltre alle forze militari guidate dal Generale Hemedti – si regge il complicato percorso verso la transizione democratica che sarà assicurata e resa definitiva solo dopo le elezioni del 2023.
Il Sudan è un paradigma per l'Africa. La rimozione del Generale Bashir e della dittatura islamista, e gli episodi violenti che hanno seguito quella fase sembravano allontanati dal processo di transizione e, per questo, quanto successo nell'ultimo mese ha particolarmente attirato l'attenzione della comunità internazionale. Su tutti gli Stati Uniti, che si sono mossi con forza diplomatica per disinnescare queste complicatissime tensioni e riallineare il paese verso una transizione a guida civile. Washington ha avuto un ruolo chiave nel supportare la transizione sudanese, rimuovendo, da un lato, il Sudan dalla lista dei paesi che fiancheggiano il terrorismo e, dall’altro, le sanzioni che tenevano bloccata l’economia.
Non è un caso che la liberazione di Hamdok (e di altri prigionieri politici) e la ripresa del percorso sia stata accompagnata da una telefonata al premier del segretario di Stato statunitense, Anthony Blinken. Il ritorno di Hamdok era una richiesta importante di Washington: l'inviato degli Stati Uniti nel Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, e l'assistente segretario di Stato per gli affari africani, Molly Phee, hanno tenuto ripetuti colloqui con i leader militari sudanesi e con diversi partner regionali molto attivi sul dossier (come gli Emirati Arabi Uniti) per pressare verso un nuovo accordo – che includeva appunto il reintegro del primo ministro spodestato.
Non c'è dubbio che ciò che serve adesso sia la piena attuazione dell'intesa tra Al Burhan e Hamdok, oltre alla creazione di un consiglio legislativo di transizione, al rilascio di tutti i leader civili e le figure detenute in relazione al golpe militare e alla revoca dello stato di emergenza che è stato imposto durante il colpo di stato. In questo processo è altrettanto indubbio che Khartum debba essere accompagnata – e, con gli Stati Uniti, è l'Unione europea che può guidare questa assistenza.
Anche perché la situazione resta complicata. Il ritorno di Hamdok sposta indietro le lancette a prima del golpe, quando tra le due sfere di potere interne al Sudan esistevano comunque tensioni. Il lavoro che il premier si trova davanti è difficile e passa da una riforma generale del sistema per assicurare il futuro del paese.
Da mesi gli apparati sudanesi paramilitari temevano l'arrivo del progetto di riforma dell'esercito, con cui Hamdok avrebbe epurato dai gangli i vari militari rimasti fedeli all'ex regime e responsabili di ingerenze nel processo di transizione per salvaguardare posizioni di privilegio e interessi radicati da anni. I militari – soprattutto la struttura paramilitare Rsf (Forza di supporto rapido) che Bashir usò per reprimere le rivolte in Darfur – controllano attività strategiche come l'estrazione mineraria e avrebbero in mano la gran parte dell'economia sommersa del paese.
La transizione politica sudanese è stata negli ultimi due anni un punto di riferimento per la regione. Al riguardo, il Sudan è il ponte tra Mar Rosso e Sahel, confinante con l’Etiopia, alle prese con una guerra civile, il Chad, immerso in una transizione politica dopo la morte del Presidente Deby, e la Libia. La sua stabilità è quindi un fattore chiave per la sicurezza non soltanto del Corno d’Africa, ma anche del Mediterraneo allargato.
Non solo: con i suoi 400 chilometri di coste, il Sudan è un attore di rilievo nel Mar Rosso, un tratto d'acqua in cui ogni anno transita un terzo del commercio marittimo globale – passaggio cruciale per tutti i carichi che entrano dall'Oriente in Europa o viceversa.
In questo territorio, la cosiddetta "Troika Araba", composta da Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita, ha usato il processo di stabilizzazione post-Bashir per ricostruire un'influenza perduta – contemporaneamente l'asse turco-qatarino ha continuato a mantenere attiva la propria presenza, anche collegandosi al lato militare della transizione.
Oltre agli attori regionali, poi, non va sottovalutato il ruolo giocato dalle potenze internazionali: la Russia ha corteggiato il Sudan chiedendo un porto per posizionarvi una base navale; la Cina inquadra il paese nel vasto territorio del Corno, dove ha posizionato una base a Gibuti.
Il quadro della big picture rende evidente l'importanza del mantenimento degli equilibri interni e alimenta le ragioni secondo cui Washington e Bruxelles dovrebbero continuare a giocare un ruolo efficace nel processo di transizione e stabilizzazione del Sudan.