Turchia, India e Arabia Saudita e il nuovo rapporto con gli Stati Uniti
Come cambia la politica estera di Ankara, Nuova Delhi e Riyad nel confronto con il 47° presidente degli Stati Uniti. Il punto di vista di Stefano Marroni
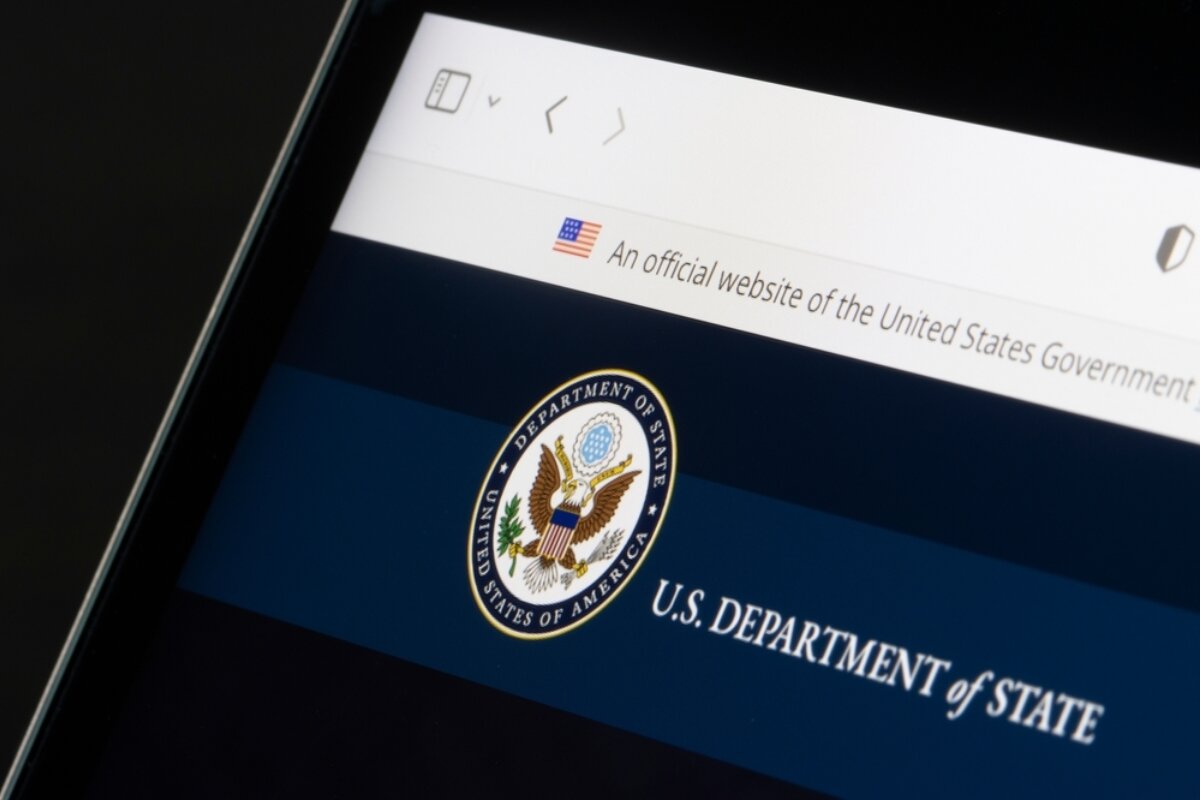
Tre outsider. Tre leader abituati a giocare le loro partite puntando sulle opportunità, più che sulle indicazioni di una qualche bussola ideologica. E a non esitare nel ricorso alle maniere forti, se qualcosa o qualcuno rischia di intralciare i loro piani. Mentre i tradizionali alleati cercano di superare lo shock delle prime mosse di Donald J. Trump, e si affannano a definire le loro contromosse palesando disagio e divisioni, emerge un fronte inedito di soggetti a cui il ritorno alla Casa Bianca del tycoon sembra aver aperto invece una finestra invitante, ridefinendone il ruolo nel loro teatro di riferimento e sulla scena globale. Chi guida Turchia, India e Arabia Saudita sembra aver molto da guadagnare e pochissimo da perdere nel confronto con il 47° presidente. E sembra pronto ad approfittarne.
Le condizioni per lavorare bene con Trump ci sono in apparenza tutte. Per cominciare – è non è fattore da poco - Recep Tayyip Erdogan, Narendra Modi e Mohammad bin Salman vantano un rapporto personale con il comandante in capo così buono che in tempi diversi Trump ha potuto dire di ciascuno di loro che è “un buon amico”. Pesa un’affinità di stile che salta abbastanza agli occhi. E pesano molto gli interessi che il Trump imprenditore e la sua famiglia hanno sviluppato nell’arco di trent’anni con i suoi autorevoli amici.
Per dirla con il Washington Post, almeno dagli anni 90 - ad esempio - l’Arabia Saudita per Trump “non è stato solo un alleato, ma anche un cliente”. Ed ha continuato ad esserlo anche dopo la sua prima elezione alla Casa Bianca: “I sauditi? Vado d’accordissimo con tutti loro”, spiegò in un comizio nel 2015. “Comprano appartamenti da me, spendono quaranta, cinquanta milioni di dollari... Perché non dovrebbero piacermi? Mi piacciono molto, invece…”.
Il peso di questa relazione speciale spiega probabilmente perché il primo viaggio di stato di Trump, nel 2017, fu proprio in Arabia Saudita. E si manifestò con chiarezza quando l’anno successivo la prima amministrazione Trump sorvolò - sostanzialmente – sui sospetti che legavano gli uomini dell’erede al trono alla sparizione del dissidente Jamal Kashoggi, continuando a fornire a Riyad armi e sostegno politico. Sulla stampa americana fece rumore, allora, la notizia che un fondo controllato dalla famiglia reale saudita avesse investito 2 miliardi di dollari nella società di Jared Kushner: genero di Trump, suo consigliere politico, e sponsor fondamentale dell’ascesa di Steve Witkoff, l’immobiliarista di origini ebraiche con giganteschi interessi nel Golfo che nel secondo mandato il presidente ha nominato inviato speciale per il Medio Oriente, e gran tessitore nelle ultime settimane della trattativa che metterà faccia a faccia a Riyad Trump e Putin a discutere del destino dell’Ucraina.
Anche per questo, nella partita che si gioca in Medio Oriente, Trump conta di aver carte migliori di Biden, che pure prima della guerra a Gaza era a un passo dal chiudere con bin Salman un accordo di sicurezza militare in chiave anti-Iran che avrebbe cambiato gli equilibri della regione, sulla scia degli accordi di Abramo. Fin qui, i sauditi hanno snobbato le soluzioni delineate dagli Usa per sciogliere il nodo palestinese e in particolare per il futuro della Striscia. Ma a Washington ostentano ottimismo, convinti che la possibilità di cospicui aiuti militari da un lato e di mastodontici investimenti nell’economia americana dall’altro (Trump ha parlato di 900 miliardi di dollari) spingerà i sauditi a favorire una qualche soluzione del problema palestinese e a venire in qualche modo a patti con Israele. Su questa strada, con gli iraniani in ritirata e già alla ricerca di un qualche appeasement con i vicini del Golfo, l’Arabia Saudita potrebbe rapidamente trasformarsi in un fattore decisivo di stabilità in quella che da decenni è la più instabile area del pianeta.
Quel che è vero per bin Salman, è a maggior ragione vero anche per Erdogan, l’altro grande attore della scena mediorientale uscito fortissimo dalla crisi siriana, e ormai pronto a giocare un ruolo di promo piano anche nella soluzione della partita ucraina, dopo aver a suo tempo mediato l’accordo sul grano e ancora prima sfidato Vladimir Putin fornendo a Zelensky i droni offensivi che a lungo hanno tenuto in scacco le truppe russe.
Anche Erdogan è un vecchio amico di Trump, che non ha mai nascosto la sua stima per il presidente turco: “Ormai ho imparato a conoscere molto bene la Turchia e i turchi. Sono gente sorprendente, incredibile. E hanno un leader forte”, diceva già una decina di anni fa il presidente. Anche In Turchia la Trump Organization ha interessi importanti, soprattutto nel settore immobiliare. Che nel solo triennio 2015-2018 gli hanno fruttato – secondo le carte dell’Irs venute in possesso del New York Times - un profitto netto di quasi 3 milioni di dollari. Niente di strano, perciò, che il 6 novembre la borsa di Istanbul abbia celebrato la vittoria di Trump con un rialzo del 3 per cento e un balzo nelle quotazioni della lira turca, nella convinzione - diffusa tra gli operatori e alimentata dal governo - che il rapporto di Erdogan con Trump possa aprire la strada a una diminuzione dei dazi americani sul tessile e sull’acciaio turchi e favorire la ripresa di una economia stagnante.
Con gli Usa, Erdogan ha da tempo soprattutto due partite aperte, che il ritorno di Trump potrebbe contribuire a chiudere. La prima è il sostegno politico e militare che dopo le primavere arabe e la nascita dell’Isis Washington ha offerto ai miliziani curdi in Siria, finiti in una posizione molto difficile dopo l’ascesa al potere a Damasco degli islamisti sostenuti da Ankara e la decisione del Pkk di chiudere con la lotta armata. La seconda - per un uomo che non esita a far arrestare i suoi oppositori politici, come è accaduto nei giorni scorsi al popolare sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu e a decine di suoi sostenitori - è l’asilo offerto dagli americani al suo oppositore più noto, il carismatico Fethullah Gulen, che dalla fine degli anni ’90 vive esule in Pennsylvania e Erdogan considera il regista del tentato colpo di stato del 2016.
Secondo alcuni degli ex collaboratori di Trump - tra cui l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton - messo sotto pressione da Erdogan Trump tentò invano di mettere l’Fbi sulla tracce di Gulen per costringerlo a lasciare il paese, e cercò in ogni modo di ostacolare le indagini della procura distrettuale di New York sul caso della Hallbank, una banca di proprietà turca i cui funzionari erano sospettati di vari illeciti finanziari e soprattutto di contribuire ad aggirare le sanzioni contro il regime iraniano: una indagine - secondo Erdogan - figlia di una “vasta cospirazione” ordita da uomini vicini a Gulen.
È però nel giardino di casa, sul terreno, che la Turchia rischia di diventare decisiva, nel nuovo assetto geopolitico prodotto dalle scelte di Trump. Il disimpegno graduale ma strategico annunciato dagli americani per concentrare forze e risorse nell’area indopacifica apre un vuoto che in Medio Oriente Israele non può colmare da solo. Ma è soprattutto in direzione del bacino del Mediterraneo e del Mar Nero che Erdogan punta a giocare la sua partita, forte di un esercito grande e ben armato, e di una qualità dei rapporti con Mosca assolutamente unica per un paese Nato, che a suo tempo – sfidando le ire di Washington - ha persino acquistato dai russi un sistema d’arma sofisticato come i missili S-400.
Erdogan si è esibito in autentici capolavori di equilibrismo. Ha bloccato il Bosforo per impedire alla flotta russa di rinforzare il suo dispositivo davanti ai porti ucraini e condannato l’invasione, ma non ha chiuso il suo spazio aereo né applicato le sanzioni alla Russia, continuando a comprare il suo gas. Così, nella partita che si aprirà all’indomani della cessate il fuoco in Ucraina, i turchi potranno far valere i crediti maturati nel rapporto con Kiev e costituire in potenza il nerbo della forza di interposizione disegnata dalla cosiddetta colazione dei volenterosi: un ruolo che li vedrebbe probabilmente più accetti ai russi delle forze europee, e che insieme potrebbe costituire una carta di credito importante per far saltare il no soprattutto francese che da decenni tiene la Turchia fuori della soglia dell’Unione.
Tra tutti, però, è certamente Narendra Modi lo spettatore più attento e interessato all’eterodossia con cui Trump sta riscrivendo le regole della geopolitica mondiale. L’India ha messo da parte da tempo il non allineamento che fu la bussola della sua politica estera tra la fine della seconda guerra mondale e la fine della guerra fredda, inducendola a orientare nel senso di un dirigismo di tipo socialista la sua economia e a tenersi a buona distanza dagli Stati Uniti, intessendo - anche in contrappeso all’ingombrante vicino cinese – stretti rapporti economici e militari con l’Urss prima, e la Russia poi. Ma lo strappo impresso dalla Casa Bianca al sistema delle sue alleanze tradizionali, in nome di rapporti one-to-one con le altre potenze globali, si prospetta come simmetrico al multilateralismo che con Modi è diventato il nuovo mantra della politica di Nuova Dehli, che punta a ritagliarsi un ruolo globale nello scacchiare indopacifico e non solo: per esempio intese con vari paesi europei tra cui l’Italia, e incassando a fine febbraio – durante la visita ufficiale di Ursula von der Leyen in India - l’impegno a siglare un accordo di libero scambio con l’Unione europea “entro quest’anno”, in quel che si prospetta come una prima risposta del Vecchio Continente alla guerra dei dazi ingaggiata da Washington .
Con Joe Biden nello studio ovale, rompendo vecchi tabu, l’India è entrata nell’alleanza militare con Stati Uniti, Australia e Giappone sopranominata Quad, dopo aver dimezzato in pochi anni l’acquisto di sistemi d’arma dalla Russia: ma Trump – che ha ricevuto Modi a metà febbraio e punta a ricambiare la visita entro l’estate – spinge per aumentare l’import indiano di gas e armi americane, spingendo forte per una corposa fornitura di caccia F-35 Stealth, che ridisegnerebbe la struttura di difesa indiana.
Nella logica di Modi, il disgelo tra Usa e Russia perseguito dal tycoon è un’eccellente notizia. In generale, perché “ogni volta che è salita la tensione con Mosca – riassume il suo pensiero Foreign Policy - l’Occidente è stato più compiacente con Pechino”. E poi perché da un lato la fine della Guerra in Ucraina libera l’India dall’imbarazzo delle sanzioni per i propri rapporti con Putin e probabilmente renderà meno indispensabile al Cremlino il “legame eterno” con l’alleato cinese. E dall’altro - al di là delle oscillazioni nei modi di Trump con Xi Jinpi – rende esplicito il riposizionamento strategico del dispositivo militare Usa nell’Indopacifico teorizzato dai falchi come il vicesegretario alla Difesa Elbridge Colby, che indicano nella Cina e nelle sue ambizioni di potenza globale la principale minaccia per l’America.
Su questo sfondo, Trump e Modi hanno ricominciato a tessere la loro tela scambiandosi favori: “Sono lieto di annunciare l’estradizione in India di Tahawwur Rama, una delle persone più malvage al mondo”, ha annunciato Trump, parlando dell’uomo di affari di Chicago che l’India considera responsabile dell’attacco terroristico del novembre 2008 a Mumbai. E l’India - che vanta un surplus commerciale di 32 miliardi dollari con gli Usa - prima ancora di iniziare a discutere con la Casa Bianca ha tagliato unilateralmente i dazi sull’export Usa dal 13 all’11 per cento. Senza fare una piega dinanzi alle immagini dei cittadini indiani deportati in catene dagli Stati Uniti: “Chi entra illegalmente in uno Stato commette un reato”, ha sentenziato Modi poche ore prima di entrare nello Studio Ovale. “Deve venire fermato ed espulso”.
Ripartendo da Washington, Modi – che secondo un Trump insolitamente modesto, riferisce The Hindu - “è un negoziatore persino più tosto di me” – ha fatto sapere che “Usa e India si sono dati l’obiettivo di più che raddoppiare il nostro interscambio, arrivando entro il 2030 a 500 miliardi di dollari. Abbiamo messo al lavoro i nostri team per chiudere molto reso un accordo di scambio di cui beneficeranno molto entrambe le parti”. Musica, per le orecchie di “The Donald”.



