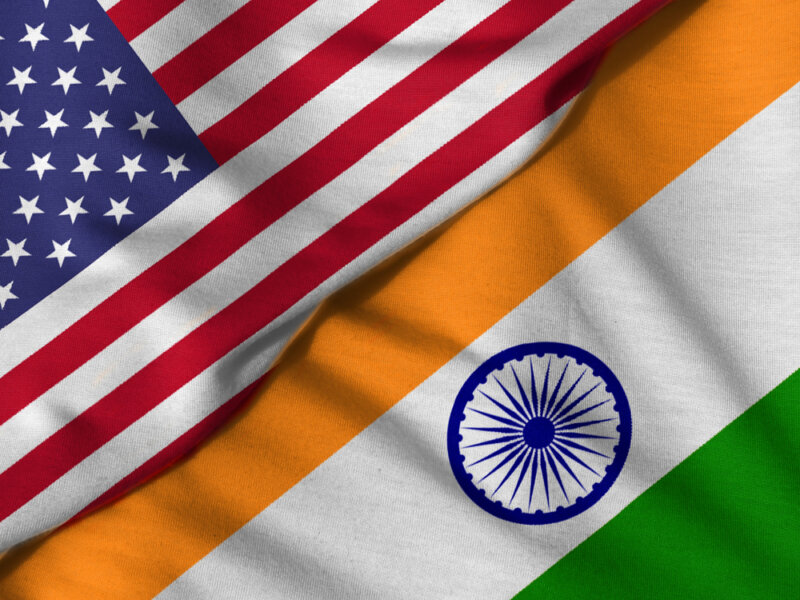USA 2024: il risultato elettorale e il ritorno di Trump alla Casa Bianca
La lunga corsa presidenziale americana si è conclusa con la vittoria di Donald Trump contro Kamala Harris. Il punto di Stefano Marroni

Non è stata una landslide, una valanga come quella che nella politica americana rimarrà associata per sempre a come nel 1984 Ronald Reagan portò a casa i voti di quarantanove stati su 50. Non è stato un record assoluto nemmeno il ritorno alla Casa Bianca di un ex presidente già battuto dal suo predecessore, anche se per trovarne un caso uguale bisogna tornare al 1892, quando il democratico Glover Cleveland sconfisse il repubblicano Benjamin Harrison. E bisogna tornare indietro comunque di vent’anni, e cioè al 2004, per l’ultima volta in cui un repubblicano, George W. Bush, batté anche in termini di voti assoluti il suo competitor, mettendo insieme oltre 62 milioni di voti contro i 57 di John Kerry. Anche se Trump, questa volta, ne ha conquistati oltre 71.
Di certo però, per la sua dimensione e per la distribuzione del voto, la vittoria che ha incoronato trionfalmente Donald J. Trump quarantasettesimo presidente degli Usa mette insieme quasi tutti gli elementi che trasformano un fatto politico in un evento epocale: indipendentemente dagli effetti che avrà sull’economia e sulla politica internazionale degli Usa. La maggioranza assoluta degli americani – oltre il 52 per cento, secondo le ultime rilevazioni – conserva un’opinione sfavorevole sul tycoon di New York. Sul suo capo gravano ancora una settantina di capi di imputazione – dall’incitamento all’insurrezione alla frode fiscale, alla corruzione, alla aggressione sessuale – ciascuno delle quali da solo avrebbe stroncato la carriera di chiunque altro. E se davvero farà anche solo un terzo delle cose che ha promesso di fare – arrestare i giudici “infedeli”, deportare undici milioni di immigrati, usare l’esercito per sedare le rivolte urbane, liberare gli assalitori di Capitol Hill – la democrazia americana cambierà e di parecchio.
Eppure, quasi il 52 per cento degli elettori ha deciso di non tenere conto nemmeno dei quasi ottant’anni di Trump per affidargli un paese alle prese con due guerre aperte e almeno un’altra alle porte: una nazione afflitta da problemi giganteschi, che pensano solo lui sia in grado di “mettere a posto”. Dando il segnale che attorno all’ex star di “The Apprentice” - ancora una volta osteggiato dai media mainstream e (ferocemente) dal vecchio establishment repubblicano - è maturata una svolta epocale nel costume, nella cultura, nelle appartenenze del popolo americano: un cataclisma politico-sociale che grazie anche agli errori dei democratici e in primo luogo di Joe Biden - ha scritto su The Atlantic Tyler Austin Harper – ha anzitutto visto il Gop che fu dei miliardari, dei Rockefeller e dei Bush, diventare “un movimento multietnico della classe operaia”.
Nell’opinione pubblica democratica, sotto shock e sinceramente impaurita, è partito subito il processo ai singoli, possibili colpevoli. E in primis a Kamala Harris, a una candidatura miracolosamente cresciuta in solo cento giorni ma forse oggettivamente troppo fragile per fronteggiare uno degli uomini che nel bene o nel male è tra i più conosciuti d’America. La sorte della “vicepresidente impopolare di un presidente impopolare” - ha scritto ancora The Atlantic - era segnata in partenza dal fatto che “dopo quattro anni al suo fianco non poteva prendere le distanze da Biden: né sull’inflazione, né sulla crisi della immigrazione illegale, né sulla politica mediorientale. E - soprattutto - non poteva dire che il suo capo non era più da tempo in grado di fare il presidente degli Stati Uniti”. Anche perché negare la verità – ha scritto parlando di Biden Matt Bai sul Washington Post – non è una strategia: “Non puoi dire agli elettori che quel che vedono con i loro occhi non è vero. Devi saper ammettere come vanno le cose. E se ti rendi conto che non ce la fai, devi passare la mano”.
Ma l’analisi del voto compone un quadro in cui le responsabilità individuali sbiadiscono, e proprio come in Europa ridisegna a fondo la geografia elettorale. Trump guadagna voti persino dove i repubblicani praticamente non corrono, cioè lungo le due coste, nelle mega aree urbane tra Philadelphia e Boston e tra Seattle e Los Angeles. Ma stavolta a tingersi di rosso non sono solo il Midwest rurale e il profondo Sud. “The Donald” ha stravinto nei sette battleground states che nelle ultime campagne presidenziali hanno deciso la battaglia a volte con distacchi minimi. Solo che stavolta ha preso la Georgia con un margine di +120mila voti, l’Arizona con +100 mila, il Nevada con quasi 70 mila, la Pennsylvania con più 130 mila: e anche dove ha sofferto di più, nel nord industriale del Michigan del Winsconsin, ha fatto comunque crollare quel che restava del Blue Wall, il “muro” democratico che per decenni è stato l’architrave apparentemente indistruttibile della rainbow coalition, l’impasto di minoranze etniche, élite intellettuali e classe operaia bianca che è stato per decenni il cuore dello schieramento democratico .
Trump ha sciolto come neve al sole le vecchie certezze progressiste. Quasi il 70 per cento dei maschi bianchi non laureati ma anche le loro compagne, madri, sorelle – insomma, la classe operaia – ha votato per lui, anche se la maggioranza delle donne in genere ha votato per Kamala. Trump ha guadagnato voti anche tra i giovani (che pure restano in maggioranza progressisti) e moltissimi tra i latinos: ai democratici mancano all’appello il 26 per cento di loro nonostante le scivolate di Trump sugli haitiani che mangano i cani e quelle sui portoricani come “immondizia”. Anche tra i neri – che pure restano una colonna portante del voto democratico – Harris non ha incassato questa volta le percentuali “bulgare” che spinsero potentemente Obama e Biden alla Casa Bianca: “Ma non credo possa essere una gran sorpresa per i democratici, che hanno abbandonato le classi lavoratrici – ha dichiarato tra l’amaro e il sarcastico il senatore Bernie Sanders, patriarca della sinistra americana – scoprire che le classe lavoratrici hanno abbandonato loro”.
Ma il trionfo di Trump è tale da non poter essere risolto con gli errori della cupola democratica. C’è di più, ha spiegato sul New York Times un autore spesso anticonvenzionale come Bret Stephens: “Tra i liberal c’è il rifiuto di vedere quanto profondamente estraneo e nemico sia diventato per tanta parte dell’America il moderno liberalismo economico. Per non dire che ho perso il conto delle volte in cui qualche esperto più o meno esperto – ironizza - ha provato a spiegare in tv o sui giornali che gli americani non avevano ragione di lamentarsi dei prezzi al supermercato, o del costo della casa o della macchina, o di una inesistente crisi migratoria al confine sud…”.
“Distratti dagli eventi pubblici entusiasmanti a cui assistevamo – aggiunge lo studioso Frank Bruni – abbiano perso di vista quello che conta davvero: il quadro di insieme, la soddisfazione del presente e le aspettative per il futuro. Ricerca dopo ricerca, emergeva che gli americani erano profondamente impauriti e molto pessimisti Ma la campagna non ha cambiato di segno. E nemmeno l’evento più affollato di stelle cambia un sentimento come questo: nemmeno un endorsment di Taylor Swift…”.
È una sindrome che da tempo, in Europa, gonfia le vele della destra. E un approccio che trova in un uomo di governo come Ben Rhodes, uno dei membri più influenti del NSC di Barak Obama, uno dei critici più severi: “I democratici sono caduti nella trappola di diventare i difensori più convinti del complesso di istituzioni — l’establishment — di cui la maggior parte degli americani non si fida più. Abbiamo perso il polso della rabbia che la gente ha verso le élite, contro il potere in quanto tale. E siamo caduti nella trappola di battagliare ogni giorno con la destra più becera sulle loro ossessioni sessuali, finendo per dare del bigotto o del razzista a chi non lo è. Abbiamo regalato a Trump la ricetta per vincere. E naturalmente abbiamo perso…”.